29
2014Michele Beraldo
Nella versatile sua complessità l’arte del secondo Novecento ha definito all’interno dell’astrattismo due grandi ambiti di ricerca. Da una parte l’informale, matrice pittorica attraverso la quale l’artista imponeva la sua personalità , sferrava sulla tela “attacchi†gestuali talvolta intensamente materici che davano corso ad un costrutto di immagini assolutamente libere; dall’altro versante si verificò l’esatto opposto: l’artista assumeva un controllo rigoroso della forma pittorica compartimentando il colore entro strutture lineari e geometriche di chiara ascendenza neoplastica.
Queste due differenti interpretazioni del linguaggio astratto sono avvertite all’interno dell’itinerario artistico di Arturo Baldan. Se negli ultimi anni egli ha inteso convergere il proprio lavoro lungo la direttrice concretista allontanandosi da ogni proposito pittorico, è proprio dalla pittura intesa nella sua accezione di assoluta libertà , nell’irradiarsi molteplice di colore e gesto, che egli era invece partito. Le sue prime affermazioni tenevano infatti conto delle più larghe e consolidate azioni espressive dell’action painting, riesaminate secondo un’ottica personale attraverso l’utilizzo di frementi ma al contempo misurate pennellate.
L’estendersi periferico del colore, il suo tracciarsi filiforme e centrifugo, connotava il lavoro di Baldan verso uno spazio idealmente infinito e policentrico entro il quale la dimensione dell’io rischiava di dilatarsi assieme al portato pittorico. Questa difformità tra lo spazio interiore e lo spazio esteriore, tra la centralità dell’io e la concitata mutabilità della forma dipinta, ha generato una reazione contraria: ha fatto sì che Baldan ripensasse ad un modello espressivo, non necessariamente pittorico, che ridefinisse i termini della sua progettualità artistica.
Con i primi “assemblaggiâ€, cominciati nel 2006, l’analisi del fruitore veniva proiettata in una dimensione fisica in cui la componente pittorica diventava secondaria ma non ancora del tutto irrilevante, poiché tra lo spazio bidimensionale e quello dell’assemblaggio veniva a crearsi una mobilità simbolica svincolata da criteri di regolarità e quindi ancora una volta rintracciabile all’interno della matrice informale.
È solo in una seconda fase, quando i contenuti extrapittorici prevalgono distintamente, che l’artista definisce in termini risolutivi la sua nuova ricerca; questa volta applicandosi rigorosamente nell’esercizio dell’assemblaggio, con una modalità che supera l’esperienza novorealista e si attiene invece a procedure più rigorose, sia dal punto di vista della lavorazione dell’oggetto che della sua applicazione.
L’opera è infatti costituita di singoli elementi, piccoli parallelepidi in legno rivestiti di tela e successivamente dipinti che costituiscono, nel loro dinamico insieme, un’immagine tridimensionale e al contempo duttile, in costante movimento.
La componente più rilevante dei suoi assemblaggi, quella geometrica e razionale, si salda infatti perfettamente nella struttura solo apparentemente statica del quadro. In realtà persistono elementi “instabili†poiché le differenti caratteristiche applicative, il maggiore o minore rilievo dei singoli corpi, la loro diversa inclinazione e sporgenza, comportano sulla superficie del quadro una diversa ricezione della luce e un diverso orientamento visivo.
L’artista, pertanto, configura l’opera entro coordinate variabili intercorse da dinamiche percettive differentemente strutturate, in cui la coazione visiva è superata dalla mutevole forza espressiva dell’opera stessa. Si creano così delle “opere aperte†a vantaggio del singolo fruitore il quale, non assoggettandosi alla forma finita, diviene interiormente partecipe della loro composta mobilità .
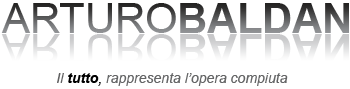
Commenti recenti